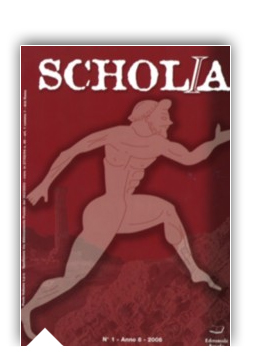
Scholia
Numero 1
Direttore: Alessandro Cesareo
Vicedirettori:
Serena Incani
Maria Rita Rossi
Cos'e' scholia:
Scholia è una rivista specifica per l'insegnamento del latino e del greco, dal punto di vista sia linguistico, sia grammaticale, sia letterario. E' un quadrimestrale, le uscite sono a Marzo, Settembre e Dicembre. Ogni numero e formato da 2 fascicoli, uno di 130 pagine, dedicato all'aggiornamento culturale e professionale, l'altro di 70 pagine, alla didattica che e gestita dai docenti del liceo classico e linguistico (molti del liceo classico Augusto di Roma.
Aggiornato secondo le ultime direttive ministeriali, offre spazio alle pubblicazioni dei lettori.
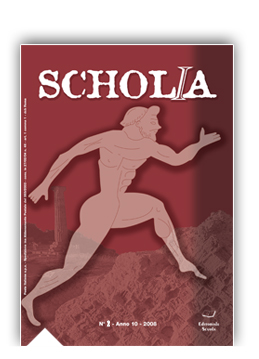 Scholia n°2
Scholia n°2
Anteprima articolo Dal n° 1:
PARLANDO DI TARDOANTICO
di Alessandro Cesareo
Lo spunto a proporre queste breve riflessioni mi viene da una conferen- za avente come argomento La storiografia in lingua latina del tardoan- tico, che ho tenuto presso il Liceo Archita di Taranto nella primavera
2010. Il mio ringraziamento va a Franca Poretti, infaticabile nella sua at- tività di docente e di responsabile della Delegazione Tarentina dell’AICC.
Mi starebbe a cuore, in realtà, tentare di avviare un minimo di dibat- tito su questo periodo della nostra storia che provvedimenti legislativi dis- sennati rischiano di cancellare del tutto dai programmi di studio, gettando così nel dimenticatoio un segmento importantissimo della complessa ed in- teressante dimensione geopolitica chiamata Europa. Suggerisco dunque questi modesti spunti, riservandomi di riprendere comunque il discorso. Un sentito grazie a tutti quanti, colleghi e non, avranno la bontà di... leggermi!
Età antica come unità integra? Ma quando s’inizia a parlare di Medioevo?
È del 1469 l’espressione del Card. Nicolò da Cusa, il quale dice: histo- ria mediae tempestatis memoria retinebat, usando appunto un’espressione che verrà ripresa nel 1493 da Hatrmann Schedel e, nel 1514, anche da Giacomo Faber. Nel 1518, invece, Gioacchino von Watt parla di media aetas, mentre nel 1519 Beato Renano introduce la media antiquitas e, nel 1532, Giovanni Heerwagen parla di medium tempus; di nuovo, nel 1575 Adriano Iunius usa l’espressione media aetas, mentre è del 1600 la locuzione media et infima an- tiquitas, introdotta, invece, da Marco Welser, nonché quella di historia mediae aetatis formulata da Enrico Canisio.
Nel 1604, Melchiorre Goldstat introduce la cosiddetta consuetudo me- dii aevi, mentre Federico Taubmann riprende l’idea di media antiquitas; è in- vece del 1612 l’espressione middle age, coniata da Tommaso James, mentre nel 1621 Enrico Neibom parla di media aetas e Rausin, storico di Liegi, nel 1639 parla di medium aevum. Emerge dunque da tali definizioni, in buona par- te elaborate nel mondo tedesco, l’idea di un’età non ben definita, probabilmen- te estesa tra Carlo Magno e Dante e comunque riconducibile a medii aevi sive mediae et infimae latinitatis scriptores: tali, almeno, vennero definiti da Gerar- do e Giovanni Vossio, nonché dal Duchesne, gli scrittori di questo lungo ed ampio periodo. Si andava dunque confermando l’idea progressiva di un’età in- termedia, assai variopinta e complessa, ed al cui interno gli eruditi individua- vano ambiti, fasi e fenomeni diversi. Può inoltre risultare importante, ai fini di una ricerca, riflettere, ad es., sul valore che ebbe l’Historia Media di Giusto Lipsio, ripresa nel 1648 da Cristoforo Keller nella sua Historia Medii Aevi e nel 1666 da Giorgio Horn.
Esiste comunque una difficoltà reale nello stabilire una data d’inizio per la storiografia latina del tardoantico. La tipologia delle opere ed il particolare utilizzo del latino farebbero cautamente pensare ad un periodo abbastanza pre- ciso d’inizio della storiografia del tardo antico, ovvero al V secolo e, in partico- lare, a Gregorio di Tours (538-594), la cui Historia (regni) Francorum in dieci libri, divisa in tre parti, la prima delle quali va da Adamo alla morte di San Mar- tino (397), per arrivare poi alla morte di Sigeberto (575): libri I-IV; la seconda, invece, costituita dai libri V e VI, si chiude con la morte di Chilperico (584), mentre la terza, che va dal libro VII al X, arriva fino al 591. Un interessante epilogo a quest’opera fu composto nel 594, anno in cui Gregorio morì. Pren- dendo dunque come riferimento, per il termine della letteratura latina dell’anti- chità, la dominazione ostrogota in Italia e la sua fine, la prima metà del VI seco- lo, Boezio sarebbe l’ultimo autore antico, almeno in base all’opinione di Auer- bach, sostanzialmente condivisibile nell’impianto cronologico e diacronico.
E quale ipotesi, o quali proposte, per una possibile data di conclusione del tardoantico stesso?
Il problema è aperto e sarà bene tornare a parlarne al più presto.
©2012-2013 Scholia. All rights reserved.
Pagine S.r.L. Via Gualtiero Serafino 8, 00136 Roma
P.IVA 04337971008